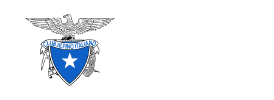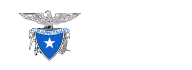Si informano i nostri soci che oggi 1 settembre è venuto a mancare Alberto Cherubini, socio ultraquarantennale della Sezione.
La salma sarà esposta dalle ore 15.00 di venerdì 2 settembre presso le Cappelle del Commiato della Pubblica Assistenza di Prato; la funzione religiosa avrà luogo sabato 3 alle ore 11.00 presso la Chiesa di Santa Maria delle Carceri.
La sezione si stringe intorno alla famiglia di Alberto e fa le più sentite condoglianze.
La dedica del cugino Luciano Paoli con la pubblicazione di 2 storie brevi scritte da Alberto:
– Oreste stava impazzendo; le mosche erano dappertutto, intorno al viso, sui bracci, sulle gambe, dappertutto. Le mosche erano le padrone della Libia o quantomeno dell’oasi di Sebha. Eppure, durante il lungo percorso nel deserto fatto per arrivare all’oasi parevano completamente sparite; nessuna traccia di esse durante le brevi soste. Arrivati a destinazione erano ricomparse; un fiume di puntini neri svolazzanti e impietosi.
Ogni giorno, per associazione d’idee, non poteva fare a meno, e come avrebbe potuto, di rammentarsi della gita fatta appena pochi mesi prima ai “Faggi di Javello” e alle numerose mosche che anche in quel luogo ameno e completamente diverso, inaspettatamente vi aveva trovato.
Era lui, il chimico tintore Oreste Pacini che, in qualità di vice presidente della “Stazione Alpina Emilio Bertini” aveva organizzato tutto, insieme al Bruschi e al provveditore Bigagli. Si era dato tanto da fare e ancora ricordava il brillante incipit sui manifesti che aveva fatto affiggere dappertutto dentro la cerchia muraria della città di Prato: “ – Per domenica 6 agosto 1911 –
In questi giorni di canicola, a chi è obbligato al diuturno lavoro, nell’afa opprimente della città, deve riuscire di sommo godimento il passare una giornata all’aperto, a godere dell’aria pura e il fresco dei monti.
Nei nostri dintorni il MONTE JAVELLO è il più alto… il bel panorama che offre la sua posizione topografica, pel fresco delizioso de’ suoi rigogliosi boschi di faggi … ”
L’avviso proseguiva invitando tutti ad iscriversi al costo di lire 1,50 presso la Salsamenteria Calamai e indicando come punto di ritrovo il Caffè Bacchino. Agli escursionisti sarebbe stato servito un desinare a base di minestra al sugo e roastbeaf con contorno.
La sera precedente era eccitato, contento di quella iniziativa, aspettandosi, per la sua sicura riuscita, elogi e commenti favorevoli. Emma, la bella ed elegante figlia unica del commendator Rindi era fiera di lui.
Il posto era sicuramente bello e il panorama stupendo; nel mese di maggio vi era salito insieme al Bruschi per rendesi conto e vi avevano trovato un paradiso di odori e colori; ma nessuno dei due, tantomeno qualcuno degli altri consiglieri, aveva previsto per quel giorno umido e caldo di agosto, la presenza così massiccia di mosche e soprattutto di noiosissimi tafani.
L’escursione fu rovinata; molti si difesero sferzandosi di continuo con rami e ramettoli carichi di fogliame, altri, pochi, sembravano quasi indifferenti dal fastidio procurato da quegli insetti ma, altri ancora brontolando, scesero quasi subito con le signore che, per l’occasione avevano esibito, insieme a delle calzature adatte, delle leggere “mise” pensate per una gita all’aperto, avviandosi verso Figline senza neppure aspettare la pastasciutta.
La settimana successiva, nella sede di via Altopascio 137 Oreste presentò le sue dimissioni. I consiglieri espressero soltanto delle tiepide obiezioni di cortesia, ma non le respinsero.
Così in quell’oasi, quegli insetti, non solo erano odiosi almeno quanto quelli pratesi e tremendamente insopportabili, ma gli rinnovavano, pungente e fastidioso, il dispiacere per il suo fallimento come dirigente della “Stazione Alpina Emilio Bertini”.
– Oreste Pacini era appunto un chimico tintore. Il suo babbo operaio follatore era morto ancor giovane e la sua mamma, a forza di cappelli di paglia, lavorando giorno e notte si era svenata per farlo studiare. E lui l’aveva ripagata diplomandosi con onore alla “Regia Scuola per le industrie Tessili e Tintorie” di piazza Ciardi. Già da qualche anno lavorava alla Tintoria della Kössler-Mayer sulla via Bolognese, che tutti comunemente avevano ribattezzato come “Fabbricone”, non senza motivo, ospitando quel gran complesso di fabbricati più di mille operai.
Al Fabbricone nessuno, tantomeno il suo diretto superiore, l’austriaco ingegner Hugo Kramer, direttore delle lavorazioni a umido, si aspettava che Oreste Pacini partisse volontario per la guerra contro i turchi. Non erano molti i diplomati in Chimica Tintoria in giro per poterlo sostituire. La Regia Scuola aveva fama di essere severa e selettiva.
Eppure Oreste gli era sempre sembrato ambizioso e lontano da quell’idee; aveva cercato di farsi strada anche dando qualche gomitata di troppo all’altro tintore. Essendo più giovane e più aperto dell’anziano collega si era mostrato audace nell’uso dei primi coloranti allo ”zolfo” per la tintura diretta su cotone; inoltre il Pacini appariva disinvolto e sicuro anche nell’applicazione di tecniche quasi dimenticate come l’utilizzo della “robbia” per la tintura della lana, la cui coltura era ritornata ad essere conveniente a causa dell’aumento enorme del prezzo dei rossi artificiali.
Ma Oreste si sentiva insoddifatto; gli pareva di non avere dall’ingegnere quei riconoscimenti professionali che sentiva ampiamente di meritare.
A questa latente e quotidiana frustrazione veniva adesso ad aggiungersi il recente schiaffo subito come dirigente dell’Associazione Alpina. In più le cose con la signorina Emma non andavano molto bene, la rottura sentimentale era alle porte; anche lei, intercettando di straforo ai “Misoduli”, certi salaci e dissacranti commenti tipici dei pratesi, si era sentita umiliata
– Era successo dunque che Oreste, sentendo distintamente di valere qualcosa e non avendo ancora trovato l’ambito che lo valorizzasse davvero, si fosse guardato intorno.
Così gli venne in mente che fosse cosa adatta a lui la politica, per la quale in giro c’era un gran fermento. A Prato, come da altre parti ma anche di più, da anni era forte la tensione tra “clericali” e “anticlericali”, tra “signori” e operai, tra ricchi e poveri. Forte in città era anche l’influenza anarchica; il pratese Gaetano Bresci che nel 1900, a Milano, aveva sparato al re Umberto I era stato il promotore, pochi anni ancor prima, di un clamoroso sciopero del Fabbricone.
Per contro in città non si viveva proprio male e ci si poteva anche divertire: caffè dotati di sale da biliardo, Accademie che diventavano sempre di più sale da ballo, Circoli e Filarmoniche con la banda cittadina che si esibiva in pubblici concerti in piazza Mercatale.
Il calcio praticato fuori della Porta Fiorentina e il ciclismo degli albori stavano affiancando l’attività ginnica che era stata una sorta di distintivo vagamente ideologico risorgimentale. Poi c’erano i saltimbanchi, il teatro dei burattini, le commedie all’Arena Rossi e i concerti popolari, mentre il teatro Metastasio dopo un lungo periodo di chiusura, aveva riaperto da tempo sfoggiando il fulgore dell’illuminazione a gas.
– Ma la prospettiva della guerra italo-turca, cioè l’idea della spedizione in Libia aveva inasprito il quadro politico cittadino. In città e in Val Bisenzio si aderì allo sciopero generale della C.G.L. per sostenere il non interventismo, ideale pervaso in una strana miscela, di antimilitarismo e di avversione antimassonica e anticlericale.
Ad esso rispose una poderosa manifestazione nazionalista in favore della guerra promossa da alcuni studenti e professori del Cicognini e da un movimento trasversale composito del quale facevano parte liberali, repubblicani, radicali e una frangia di cattolici. Si sognava un’espansione colonialista sul modello inglese e francese che sarebbe stata certamente fattore di prestigio, di sviluppo economico nonché motore di commesse statali. Tutti a Prato sapevano che la stoffa delle divise dei soldati poteva essere la stoffa pratese più a buon mercato di quella della concorrenza.
Si era rivolto dunque verso la politica, della quale però, bisogna dire che non fosse proprio un neofita.
Quando era molto giovane e ancora studente della Regia Scuola di Piazza Ciardi, il Pacini aveva seguito il primo congresso Democratico-cristiano nel 1900, tenuto proprio a Prato. In quel congresso, ispirato alle idee di un prete, Romolo Murri già in odore di modernismo, sentì parlare, aderendovi idealmente, di ideali sociali e di solidarietà.
Ma poi, una volta nel mondo del lavoro, trascorrendo le sue lunghe giornate nei fumanti e danteschi stanzoni delle tintorie, fu preso via via sempre più dalla voglia di emergere, anche per ripagare i sacrifici di mamma Assuntina. Così, lentamente si era allontanato da quelle aspirazioni ideali che una volta lo avevano infiammato.
– Alcune settimane dopo la sfortunata escursione sul Monte Javello ebbe modo di conoscere il professor Amerigo Bresci, uno storico accesamente nazionalista, già “proposto” della Misericordia e fondatore dell’Università Popolare pratese. Egli, nel composito schieramento interventista, era annoverato tra i più favorevoli alla guerra.
Il famoso poeta Giovanni Pascoli nel novembre, aveva proclamato il suo famoso discorso: “ … una vasta regione… che già per opera dei nostri progenitori fu abbondevole d’acque e di messi, e verdeggiante d’alberi e giardini; e ora… per l’inerzia di popolazioni nomadi e neghittose, è per gran parte un deserto… ci torniamo… è un nostro diritto… ed è un dovere nostro.” Perfino il capo del governo, Antonio Giolitti, che inizialmente era stato titubante, aveva definito la guerra “una fatalità storica”.
Oreste che in fondo aveva un cuore portato al bene e costruttivo fu ripreso dunque dal sacro fuoco della politica anche se, a dire il vero era un fuoco di natura un po’ diversa dalla passione sociale che aveva caratterizzato quel primo congresso democristiano.
All’atto pratico indugiò non poco, ma poi, convinto di quelle forti motivazioni interventiste e dell’utilità della guerra, si decise finalmente di dare anche lui il suo contributo alla patria, per la quale avrebbe doverosamente speso, come supponeva, il suo talento.
Allora, accompagnato dai pianti e dalla disperazione di mamma Assuntina, verso la metà di marzo del 1912 si presentò al distretto e, dopo un corso allievi ufficiali un po’ accellerato, partì sottotenente con un corpo d’armata ritardatario rispetto al grosso delle truppe partite a fine settembre.
Ebbe la qualifica, essendo un chimico, di farmacista, anche se con le medicine non aveva mai avuto nulla a che fare e come tale fu aggregato alla diciassettesima sezione medica. Avrebbe avuto il compito di provvedere all’approvigionamento e alla preparazione delle medicine più necessarie come la Fenacetina, il Chinino di stato e la Tintura di iodio e gli ingredienti più utili, insieme ai ferri chirurgici per la tavola operatoria.
– Quando la nave, alla fine del mese successivo, ormeggiò nel porto di Tripoli, l’eco della strage di Sciara-Sciat era già arrivata in Italia da un bel po’, ma i giornali ne avevano attutito il clamore annunciandone, tra l’altro, l’immediata ritorsione. Poi anche Oreste insieme ai suoi commilitoni, tutti quanti provvisti di casco coloniale e di una specie di italica sahariana, seppe molto di più e inorridì.
Alla fine di ottobre, un mese dopo lo sbarco italiano, gli ottomani e le milizie libiche loro alleate avevano attaccato all’improvviso il perimetro difensivo di Tripoli, ma gli italiani erano riusciti ad evitare lo sfondamento e a recuperare le posizioni perdute durante le prime fasi della battaglia.
Nell’oasi di Sciara el Sciatt, invece, le cose erano andate molto male. La popolazione araba e berbera locale si era unita ai combattimenti prendendo alle spalle i bersaglieri e costringendo una compagnia ad arrendersi. Era stata un’insurrezione popolare che aveva coinvolto tutti, uomini e donne, vecchi e ragazzi, animati dal fanatismo religioso.
Quando gli italiani riconquistarono l’oasi si trovarono di fronte a un massacro. Quasi tutti i duecentonovanta prigionieri in uniforme erano stati trucidati. Avevano loro tagliato i piedi, strappate le mani, e poi li avevano crocefissi, inchiodati alle palme da dattero o all’interno delle moschee. Un bersagliere aveva la bocca strappata fino agli orecchi, un altro aveva il naso segato in molti punti, un terzo infine era stato trovato con le palpebre cucite con lo spago.
La reazione delle truppe italiane era stata altrettanto feroce. Secondo alcune fonti italiane vennero uccisi a sangue freddo oltre mille tra uomini, donne e bambini. Era presumibile che fossero stati invece molti di più.
– Oreste e i suoi compagni non ebbero molto tempo per ripensare a quell’orrendo avvenimento; quasi subito la sezione medica a cui apparteneva si preparò a partire in una colonna di Fiat 15, appositi autocarri fabbricati dalla fabbrica torinese, insieme ad una compagnia di genieri, verso l’oasi di Sebha distante più di cinquecento chilometri.
Oreste non aveva mai visto il deserto, se non attraverso le placide e colorate vignette della “Domenica del Corriere”. Lo spettacolo era insieme angoscioso e di quelli da mozzare il fiato: formazioni di roccia vulcanica che si alternavano a immani e accecanti distese di sabbia, perdendosi in un orizzonte senza fine. Il viaggio fu lunghissimo e spossante. Accompagnati solo dal rumore del rombo dei motori che, stanchi e assetati anch’essi ogni tanto sembrano ansimare, raggiunsero dopo molte ore l’oasi ed in particolare il villaggio di El-Gedid.
L’impatto iniziale non era stato spiacevole. Era vicina la sera e i raggi del sole erano tiepidi; l’oasi appariva fatta di colori tenui e limpidi, mentre le rade palme tentennavano sonnolente nel cielo. C’erano degli ulivi selvatici, sotto la cui verde e pallida ombra furono alzate le tende.
– Erano ore di refrigerio e di calma quelle precedenti il buio ed erano gradevoli. In quell’ore gli arabi dell’oasi facevano confluire nei canaletti d’irrigazione fatti a mano nella sabbia, tutta insieme l’acqua delle vasche che nel frattempo avevano riempito a forza di secchiate tirate su dai pozzi. Innaffiavano il granturco, l’orzo, gli ortaggi.
Ma il giorno seguente, con il sole levato alto nel cielo, la sua iniziale sensazione di gradevolezza era cambiata molto. L’oasi discretamente animata la sera, adesso era immobile come un mondo incantato. Solo dei lenti rumori qua e là di qualche carrucola che tirava su l’acqua nelle vasche e il ronzio di tante mosche moleste.
Il punto dove si era accampata la compagnia era un campo sabbioso; da un lato della vicina piazza inondata di sole c’erano delle case arabe di color ocra scuro che non avevano un tetto, solo quattro mura, avendo come tetto soltanto il cielo.
A quell’ora con il sole ormai a picco, il cielo non appariva di alcun colore essendo completamente fustigato dai raggi. Il caldo, pur essendo la fine di aprile, gli sembrò esagerato; uno spesso manto che lentamente calava su tutto e tutti. Un opprimente e tutt’altro che benevolo benvenuto da parte del deserto libico.
– Dopo un mese fu la volta del Ghibli; un asfissiante, caldo e secco alito che soffiava da sud. Un vento del deserto che trasportava e sollevava aria e sabbia prelevata dalle dune del sahara che era stato capace in passato di inghiottire interi eserciti.
Da quell’oasi ogni tanto passava una carovana di cammelli. I cammellieri facevano viaggi per il deserto che duravano due o tre mesi, durante i quali non incontravano nessuno. Avevano soltanto i sufficienti datteri per cibarsi, e incredibilmente poca acqua.
La cosa che colpiva più di tutto Oreste era la costante presenza di una presenza femminile accoccolata sul primo dei cammelli. Il cammelliere si fermava nell’angolo più appartato dell’oasi, mentre i cammelli si accomodavano biascicando continuamente con quelle lunghe bocche, poi si sdraiava sulla sabbia morbida; a quel punto poteva fare un cenno alla sua donna, ed essa lasciava la veste iniziando la lenta e voluttuosa danza del ventre, che da secoli intorpidiva gli occhi degli arabi e che accendeva adesso la fantasia dei coloniali che osservavano da lontano.
Invece all’interno dell’oasi che pur contava numerose abitazioni, sembrava che non esistesse alcuna forma di presenza femminile. Specialmente le giovani arabe, serrate dalla impalcabile gelosia dei loro uomini, erano sempre rinchiuse dentro le case e, quando ogni tanto uscivano erano completamente coperte compreso il volto dalla stoffa del loro manto, all’infuori degli occhi che, lucidi, guardavano avidi da uno spiraglio.
– Arrivò dunque il mese di agosto che fu caldissimo e secco e privo di una pur minima ventilazione.
– … oh ! signor tenente… l’è l’ora… non viene?… – Il sottotenente Oreste Pacini si scosse da quelle spiacevoli reminiscenze riaffiorate a causa delle mosche: era giusto trascorso un anno dall’escursione ai “Faggi”.
Arturo, pur essendo abbastanza in confidenza, continuava a dargli del lei e a chiamarlo tenente. Anche lui era pratese, per la precisione era del contado di Vergaio. Faceva l’infermiere ma era contadino fino all’osso ed era di poche parole. Si erano intesi bene fin dal primo viaggio interminabile tra le dune del deserto, tuttavia era difficile sapere cosa li tenesse insieme, perché erano molto diversi; forse l’esser della stessa piana e con la stessa parlata.
Mentre il chimico tintore, quando apriva bocca parlava quasi sempre di se stesso mettendosi in risalto e, se non aveva da lamentarsi di qualcosa, ogni sua parola spesso pareva una sentenza, Arturo era prudente e schivo e, pur non essendo molto istruito era sottile nei giudizi. Mostrava benevolenza per tutti e conoscenza dell’animo umano, ma sembrava volesse smorzare la fondatezza che davano le sue parole e della quale lui stesso non faceva alcun conto.
Con lui Oreste si sfogava alternando la propria saccenteria ad un’autocommiserazione condita di infelicità, che peraltro ne sembrava la diretta conseguenza, mentre l’altro lo stava a sentire attento, ma senza tanti commenti.
– Comunque all’una, anche Oreste, non avendo perso l’appetito nonostante l’amaro in bocca per quel ricordo, si sedette taciturno per il rancio sotto un olivo sbiadito, davanti al suo piatto di stagno.
Ma per lui e allo stesso modo per gli altri commilitoni, il momento del rancio era diventato quasi un patire, era croce e delizia.
Accostata la bocca fin quasi a toccare il piatto colmo di pastasciutta ben condita, con la forchetta spostava rapidamente in quel breve spazio la pasta, mentre con la mano sinistra si sventolava di continuo per impedire alle mosche di intrufolarsi nel piatto, cosa che poteva avvenire per davvero.
Ma le mosche, sprezzanti del pericolo di essere fagocitate dal chimico si mostravano incuranti di quegli inutili tentativi; così volteggiavano svelte e nervose tra teste accaldate, forchette e piatti. Anche quel giorno, nessuno tra i commilitoni, così impegnati nel dissuadere le mosche, poteva o aveva voglia di parlare. Dopo il pranzo, finalmente liberi, qualcuno accennò a qualche svogliata chiacchiera, ma alle due del pomeriggio, come per altri, la conversazione tra i due pratesi o meglio, il quasi monologo del chimico, presto languì.
Il sole incombeva immobile con le ali aperte sull’oasi, e il caldo avvolgeva sempre di più invadendoli di torpore. Così ognuno si diresse lentamente alla propria tenda infuocata e umida ma preservata almeno in parte da quegli odiosi insetti.
Anche Oreste, imbambolato e nascosto in quella specie di sudario, vi si stese immobile, per dormicchiare o pensare alle sue cose.
– Tuttavia quel giorno, nudo e sudato sotto la tenda, pensava inquieto e non riuscì neppure ad assopirsi. Era arrivato da quattro mesi e non aveva ancora visto un soldato ottomano. Per contro, aveva condotto per giorni e giorni quella estenuante e quotidiana lotta con le mosche, mentre adesso stava ripensando a come avesse fatto ad arrivare alla decisione di arruolarsi della cui saggezza non era più così convinto.
Uscì spossato da quella tenda e, sedutosi su una cassa vuota, il mento sopra i pugni e i gomiti appoggiati sulle gambe guardava per terra. Osservò lì vicino, in quella sabbia asciuttissima e levigata, oltre a qualche metallico scarabeo, uno scorpione immobile che, con la coda pronta, le mandibole forcute e aperte stava aspettando la preda. Gli rammentava l’immobilità degli arabi seduti nella striscia d’ombra; pensò che forse anch’essi fossero pronti a colpire. Si ricordò allora della strage di Sciara-Sciat; anche lì gli arabi si erano improvvisamente messi dalla parte degli ottomani.
Era partito con ideali patriottici e con l’idea sottesa che nell’esercito avrebbe avuto modo di essere maggiormente valorizzato, ma in fondo era stato mosso anche da un profondo senso di insoddisfazione, da una grande smania di fuggire dai confini angusti dell’orizzonte chiuso del suo lavoro, della sua città.
– Scese la sera e come tutte le sere le mosche si accucciavano nel tepore, silenziose, preparandosi all’aria fredda della notte.
Oreste e Arturo si incamminarono invece all’interno dell’oasi la quale, larga in totale circa tre chilometri era attraversata da una strada di sabbioso velluto, delineata sulle due sponde da fichi d’india: – … ma te Arturo, sei sposato?… – gli chiese Oreste inaspettatamente.
Era la prima volta che gli chiedeva qualcosa a proposito della sua vita privata. Fino a quel giorno, avevano chiacchierato dei fatti della guerra, oppure dei problemi della sezione tra i quali, secondo il chimico, l’inettitudine del maggiore medico che, sempre secondo lui non capiva nulla; ma quasi sempre era il diplomato con onore alla “Regia Scuola” che parlava di se stesso, delle sue ambizioni, o del mondo che ce l’aveva con lui.
Arturo non se l’aspettava ed esitò: – … son vedovo e ho un figliolo piccolo che ho lasciato alla mi’sorella… – Spiegò che si era arruolato per guadagnare qualcosa in più, ma poi aggiunse in un soffio: – … ma più che altro per ingannare i’ dolore… l’Alfonsina l’era tutto per me… –
Fece silenzio e si fermò qui. Continuarono a stare zitti tutti e due mentre ritornavano al campo. Oreste, camminando, lo sbirciava con occhi nuovi.
– Due sere dopo l’infermiere riprese il discorso quasi da sé. Pur riservato, anche lui aveva bisogno di buttare fuori qualcosa del suo vissuto. Raccontò che Alfonsina fosse stata la figlia del padrone, il quale non riusciva a sopportare che si fosse innamorata di un suo contadino. Arturo era appunto il figliolo maggiore di un suo mezzadro. Tanto fece e tanto minacciò da escluderla praticamente dalla famiglia e dai suoi beni.
– … non volevo questo… anche il mi’ babbo era contrario e diceva che lei non poteva essere la moglie adatta… troppo signora… icché potevo offrirle io, diceva, il concime delle vacche? Non pensavo che a lei… eppure vi avrei rinunciato per il suo stesso bene… – si interruppe, era imbarazzato. Non credeva che sarebbe arrivato a raccontare quelle cose lì, in mezzo al deserto a un cittadino istruito che sentiva essere di un’altra specie sociale; ma Oreste quella sera non parlava di sé e lo ascoltava attento.
– … tuttavia Alfonsina un giorno mi prese da una parte e guardandomi fissa negli occhi… non l’avevo mai vista in quel modo… disse che altrimenti avrebbe fatto qualcosa di brutto… così ci sposammo… –
Dopo un’altra pausa, con gli occhi lucidi, aggiunse: – … nessuno ci dava tanta fiducia… invece siamo stati felici… da non credere… forse troppo… un’era normale… Dopo due anni quando nacque la bambina ci parve un sogno… –
Alla seconda gravidanza andata troppo oltre il tempo, il dramma. Come raccontò, il parto era podalico e nessuno, né il medico, né la levatrice riuscì a girare il bambino, un maschio troppo grosso. Morirono tutti e due, prima il maschietto e dopo tre giorni, d’infezione, la mamma.
– Quella notte Oreste, che solitamente si addormentava subito come un sasso, non riusciva a prender sonno. Uscì dalla tenda; era freddo, ma si mise a guardare il cielo con un misto di inquietudine e di smarrimento. La sua vita, fino a quel momento, si era in gran parte retta sull’ambizione e sulla ricerca del riconoscimento per come lui riteneva d’essere.
Alfonsina aveva invece rinunciato al sicuro benessere mentre Orazio era stato costretto ad uscire dalla fattoria abbandonando la sua famiglia d’origine e inventandosi con grandi sacrifici un nuovo lavoro. Insieme avevano messo davanti a tutto l’autenticità, e si erano persi l’uno nell’altro.
Era il giorno di San Lorenzo; osservò una stella cadente e solitaria che scomparve nell’immensità. Gli parve un segno di benevolenza, forse un presagio che qualcosa di buono potessere finalmente succedere.
All’alba seguente, come tutti i giorni, il mattino mostrava i primi colori mentre le mosche erano ancora tramortite e ansiose di tepore e di caldo. Ricordando i pensieri di quella notte, sul filo dell’ironia gli venne in mente un’idea assurda: – … han dormito tutta la notte… eppure l’hanno sentita anche loro quella storia… son proprio senza cuore queste mosche… –
Ne era proprio ossessionato; tuttavia ricominciava la routine quotidiana mentre la guerra sembrava quasi dimenticata. Quell’oasi sembrava fuori dal mondo e la sezione medica, non avendo feriti da curare che arrivassero dalle zone circostanti, né c’era stata richiesta che essa stessa si trasferisse in zone dove la guerra covasse più o meno sotto la cenere, si era inventato un compito; così avevano costruito una baracca dove, uno ad uno sfilavano gli arabi e i beduini berberi.
Alle basi sabbiose delle case c’era un rigo d’ombra, entro il quale gli arabi, le spalle appoggiate al muro e la testa eretta per non incontrare il sole, si erano messi in attesa perfettamente immobili, fumando in assoluto silenzio. I loro occhi umidi sembravano spenti, ma poi d’un tratto pareva mandassero come dei lampi. Stavano accucciati in lunghe file lungo il muro di quelle case, avvolti dal barraccano.
Ma con il sole alto le mosche diventavano di nuovo le padrone del campo. Quei mantelli odorosi di pecora si ricoprivano presto di punti neri, così apparivano le mosche desiderose di caldo. Quando qualcuno della fila muoveva un braccio, come tutto il resto del corpo coperto dal baraccano, era come se un telo fatto di mosche mosso dal vento ondeggiasse; e appena dopo, sul baraccano tornato immobile si ricomponeva, anch’esso fermo, quel singolare tessuto fatto di puntini neri.
– Comunque Oreste, grazie ad Arturo aveva cominciato a considerare che anche al di fuori del suo enorme ego potesse esistere della vita. Proprio come sotto un’oasi del deserto vi si trovava l’acqua vitale per la sopravvivenza, nella vita di Arturo vi aveva trovato una scintillante e fresca falda di dignità e di sapienza contadina.
Erano diventati amici e, pur armati di tutto punto come da precisi ordini del comandante in campo, stavano apprezzando la possibilità di fare qualche passeggiata, quasi in silenzio e con il sigaro acceso. Ma ogni tanto al Pacini gli ribollivano le sue cose, e vi ritornava sopra.
Una sera l’infermiere contadino si fermò sotto una svettante palma e, girandosi verso l’amico: – … tu poi anch’andare in capo a i’mondo, ma se un tu sorti da certe fissazioni gli è come se tu fossi sempre nello stesso posto… –
Oreste lo guardò sorpreso: – … o codesta… icchè tu vorresti dire Arturo? – … tranquillo Oreste… non è farina del mi’ sacco… me lo diceva l’Alfonsina… –
Oreste continuò ad avere l’aria interrogativa; non capiva. Allora Arturo gli spiegò quanto, l’atteggiamento del suo babbo e ancor più l’intransigenza odiosa del padre di lei gli avessero lasciato, a suo tempo, una scia di sordo rancore che lo faceva star male. Avrebbe voluto, per lasciarsene dietro le spalle perfino il ricordo, allontanarsi da Prato. Lei invece gli insegnava a cercare la pace dentro al proprio cuore, piuttosto che al di fuori di sé.
– Una volta invece trovarono un’araba che camminava davanti a loro. Si muoveva incedendo come una regina. Era vestita di bianco di seta e immacolato, le braccia muovevano braccialetti e la sua spigliatezza faceva pensare che non fosse preoccupata di qualche ristrettezza.
Ad un certo punto sembrò essere arrivata presso la stretta apertura della sua casa, un’apertura così stretta da far apparire più alte le mura. Da essa, per quanto si potesse intravedere si accedeva ad uno spoglio e silenzioso cortile.
Ma d’un tratto, invece di entrarvi ella si volse indietro; i due pratesi non credevano ai loro occhi. Era a volto nudo, ridente, di bellezza e di raffinatezza inarrivabile. Fissò senza incertezza Oreste che era davanti, continuando ancora a tenere abbassata la veste e indugiando immobile. A volto ancora nudo, continuava a guardarlo sorridendo.
– … sorrideva come un’italiana… era così bella e delicata… sembrava un’apparizione… – dirà il chimico più tardi. In effetti aveva capelli neri e lucenti, il volto ovale, la bocca morbida e disegnata con esattezza. Il modo come teneva il lembo della veste era di un’eleganza naturale. Infine fece salire la stoffa che avrebbe chiuso il volto, poi alzò la mano, racchiuse l’apice del lembo ed entrò.
Incredibilmente, mentre i due non si erano ancora mossi da lì continuando a guardarsi stupiti, dopo pochi attimi lei riapparve; la mano che tratteneva la veste scese rapida e di nuovo ne apparve il volto, ma questa volta quasi implorante; i due occhi grandi erano come dicessero moltissime parole.
Nessuno dei due seppe come reagire, tantomeno Oreste rimasto impietrito. La bellezza, il mistero di quell’implorazione, il sorriso che l’araba gli aveva prima rivolto, lo aveva confuso.
In quel momento dalla stretta apertura comparve un arabo, alto, nerboruto, il volto pieno di fitti peli, gli occhi iniettati di odio; contrasse due o tre volte i tratti del viso e gridò parole incomprensibili.
Arturo, più padrone di sé e meno impressionabile dell’amico, prese subito Oreste per un braccio quasi strattonandolo e lo portò via di lì, mentre l’arabo, da dietro, continuava ad inveire.
Il chimico tintore dimenticò presto le supposte minacce dell’arabo ma ricordò ancora a lungo quella giovane donna; la sua immagine continuò ad abitare e a consolare la sua fantasia nelle fredde notti libiche.
– Poi un giorno di settembre successe quello che Oreste non pensava potesse più succedere. L’esercito turco, sostenuto da forze irregolari arabo-berbere, attaccò gli italiani in quell’oasi da essi perduta nel novembre precedente. Le guarnigioni di genieri e di bersaglieri che vi erano di stanza, preavvertite, si erano organizzate sebbene all’ultimo momento, ma avendo già da tempo le trincee pronte.
Anche la sezione medica era pronta e le istruzioni precise: i morti sarebbero stati da mettere li, i feriti da trasportare là. Pronti anche i dottori già sbracciati con il grembiulone bianco; le barelle preparate, i ferri chirurgici allineati sopra la tavola dell’ospedale di combattimento; l’odore, anzi il puzzo dell’acido fenico, dell’etere, dello iodoformio che non incoraggiava nessuno.
Gli ottomani li investirono subito con uno scoppio serrato di artiglieria e con un nugolo impressionante di colpi di fucileria. Non lontano dalla baracca medica dove si era piazzato un plotone di bersaglieri ne caddero subito in quattro. Un altro, che era al riparo di una palma ebbe la coscia traforata orribilmente da un colpo. Anche un ufficiale perse un dito mentre stava sparando. Il campo sembrava un inferno, tanto nutrito era il fuoco. Arturo insieme ad altri fu mandato vicino alla linea più calda con le barelle.
Gli italiani comunque, dopo il veemente attacco iniziale del nemico ripresero in mano la situazione; nelle trincee avevano impiantato micidiali batterie di mitragliatrici. Dopo due ore di fuoco continuo e l’uscita della fanteria che caricava alla baionetta, affiancata dai mezzi motorizzati dei bersaglieri, gli ottomani e le truppe libiche ribelli ripiegarono, lasciando sul campo disseminato di fez rossi centinaia di soldati morti.
– Rientravano a più riprese i barellieri carichi di soldati italiani feriti, mentre Oreste coadiuvava i medici nella baracca dei tavoli operatori, ma ogni tanto ne usciva fuori a cercare con lo sguardo; era preoccupato perché da ore non vedeva Arturo.
Lo trovarono più tardi con il suo compagno barelliere, entrambi mutilati e in un lago di sangue.
Oreste rimase stordito, non se ne capacitava, ma non avendo il tempo per pensarci non riuscì neppure a piangere. Era preso in modo frenetico dal suo lavoro; c’erano decine e decine di feriti e di moribondi a cui pensare.
A sera tardi, sfinito, riprese fiato e realizzò che aveva subito una grande perdita. Sporco di sangue e sudato, era seduto da poco in disparte dove finalmente poteva piangere il suo amico quando, un’ombra sbucò fulminea da dietro gli olivi. D’istinto ebbe soltanto il tempo, senza girare lo sguardo, di spostarsi appena, mentre quell’ombra diventava un arabo che brandendo un lungo pugnale, urlando, dopo aver colpito Oreste al braccio sinistro se la dette a gambe. L’arabo fu rincorso e ucciso immediatamente.
Il chimico fu operato subito in quella baracca che proprio lui aveva contribuito a preparare e a fornire dell’occorrente, ma il braccio che risultò irrimediabilmente compromesso gli fu amputato.
– Fece relativo scalpore, pur in mezzo a tanto dolore e a tanta morte, il fatto che l’attentatore, fornitore di datteri e ortaggi per la guarnigione, fosse conosciuto come persona apparentemente pacifica e collaborativa. Prima dell’attacco c’era stato un certo sentore di insurrezione alimentata di fanatismo religioso e l’autorità militare aveva provveduto ad arrestare i maggiori sospettati, tra i quali evidentemente non figurava quell’arabo.
Anche qui com’era successo a Sciara-Sciat quasi un anno prima, la reazione dei coloniali, nei riguardi della popolazione dei tre villaggi dell’oasi, senza fare tante distinzioni tra coloro che si erano ribellati e i civili inermi, fu crudele ed esagerata.
Il giorno seguente furono impiccati diversi di quegli arabi traditori. Mentre il corpo di uno penzolava al nodo scorsoio lungo il tronco di una palma, una famiglia araba fu ritrovata nei dintorni da una pattuglia di cavalleria. Della famiglia faceva parte un giovanetto di quindici anni, il quale, vedendo quel corpo ciondoloni, tirato fuori un coltello nascosto sotto il barracano, se ne inferse un colpo alla gola. Oreste, che assistè all’accaduto, rimase sconvolto.
Dissero che era stato un tradimento di fiducia. – … con questa gente non c’è mai da fidarsi… questa brutta gente… ma come ha fatto la natura a farli così orribili?… sono come le belve… – gridavano in tanti ancora eccitati.
Lui, pur mutilato e dolente per se stesso, e tuttora molto addolorato per la perdita dell’amico, sentiva comunque che in tutto questo c’era qualcosa che non tornava.
– Intuiva adesso che essi apparissero agli arabi semplicemente come stranieri che, senza essere invitati, erano arrivati lì con il pretesto di far rifiorire le stentate coltivazioni, pur poste in ricche piantagioni come recitava la propaganda interventista, e riattivare in commerci floridi i commerci carovanieri un tempo ricchi ma ormai in decadenza.
La propaganda aveva coniato l’immagine dell’arabo desideroso di scrollarsi di dosso l’oppressione ottomana e quindi pronto a schierarsi con gli italiani quando fossero sbarcati. Invece, una volta arrivati camminarono e spadroneggiarono armati in un paese altrui, aggredendo e uccidendo.
D’altra parte, poco prima di essere pugnalato, aveva visto lui stesso la scena dei quattro bersaglieri che giacevano a terra a pochi passi l’uno dall’altro, immersi in un lago di sangue; erano orribilmente straziati e mutilati, in uno stato irriconoscibile. I turchi e i loro alleati avevano sfogato tutto il loro odio sulle salme dei soldati.
Ricordava la raffinatezza e la bellezza di quella misteriosa e giovane donna e gli occhi pieni di odio di quell’arabo sbucato dalla sua abitazione. In quegli occhi non c’era solo gelosia, ma anche rabbia repressa contro i due estranei che in quel momento erano visti come l’invasore: – … c’è poco da fare… odio… odio dappertutto… –
Quell’amputazione, durante i giorni seguenti, fu vissuta dal Pacini molto male. A parte il dolore fisico e l’angosciante consapevolezza del futuro impedimento, essa rappresentava come la morte di una parte di sé, la parte che maggiormente lo aveva identificato fino a quel momento; quella di una persona convinta delle sue idee politiche e della bontà di quella guerra, quella di una persona determinata nella sua ambizione di emergere, sicura del fatto che, se fin’allora non era riuscito allo scopo, ciò fosse dovuto ad un puro caso.
Oltretutto la perdita del suo amico, forse il più sincero e onesto ch’egli avesse mai incontrato, continuava a prostrarlo profondamente. Quasi ancora non ci credeva.
– Un giorno, mentre mesto e ancora un po’ febbricitante sedeva presso la sua tenda, una mosca, una più grossa e lustra del solito, smettendo di svolazzare, gli si posò sopra il moncherino fasciato. Niente affatto intimorita, mentre dimenava le zampette davanti, pareva guardarlo.
D’un tratto, gli sembrò che quella mosca, anzi ne era proprio sicuro, attraverso il suo ronzio gli volesse parlare. E infatti gli parlò davvero: – … Oreste… sono Arturo… sono io, ma non ti preoccupare… io sto bene… c’è anche Alfonsina qui… sono felice. Lei ti vuole dire che un giorno sarai contento… sì… perché ritroverai te stesso… farai del bene… e il tuo cuore sarà sereno… –
Oreste si riscosse, capì che si era un po’ addormentato; però era contento lo stesso. Il suo amico non l’aveva proprio abbandonato; era invisibile agli occhi ma gli avrebbe parlato attraverso il cuore.
Si tirò su con energia rinnovata e poi si alzò in piedi con la voglia di fare qualcosa; così si affacciò alla baracca medica: – … ragazzi… posso dare una mano? – L’ironia era stata involontaria, ma ebbe l’effetto benefico, dopo tanto male, di far ridere sonoramente tutta la sezione medica.
– Dopo un mese il sottotente chimico fu rimandato in Italia in congedo illimitato con la promozione a tenente. Arrivò a Prato senza un braccio e con la fede interventista molto ammaccata, anzi mutilata gravemente. Poiché c’era scarsità di chimici, obtorto collo fu assunto di nuovo dall’ingegner Hugo Kramer alla Tintoria della Kössler-Mayer; disse che le ricette le avrebbe fatte anche con una mano sola e che l’importante fossero gli occhi buoni: – Pacini… non ti arruolerai un’altra volta eh? – soggiunse sarcastico. Oreste invece fece di meglio.
Due anni dopo, nel 1914, imperversando di nuovo la furia interventista con alla testa D’Annunzio, il sindacalista Mussolini e l’irredentista Cesare Battisti, questa volta invocanti la liberazione di Trento e Trieste, Oreste si mise con altri a Prato alla testa del movimento neutralista. In particolare era il trascinatore della frangia democratico-popolare, che interpretava le esigenze delle classi medio-povere, ben lontane dalla guerra.
Intervendo senza risparmio nei circoli, nelle sacrestie, nelle accademie e nelle filarmoniche, andando senza timore perfino ai “Misoduli”, gridava che la guerra sarebbe stata un’insensatezza e che non poteva credere che l’uomo potesse ricascare di nuovo nella barbarie: – … vi dico che in futuro, l’uomo liberato finalmente dall’ignoranza, non penserà mai più alla guerra… la guerra non risolve nulla… sì… ne son sicuro… mai più la guerra …–
Non ebbe paura di nulla, neppure delle battute sarcastiche dei benpensanti, ma non si sentiva solo; ogni tanto saliva su a Javello dove una mosca più lustra del solito gli ronzava intorno consigliandolo.
fine